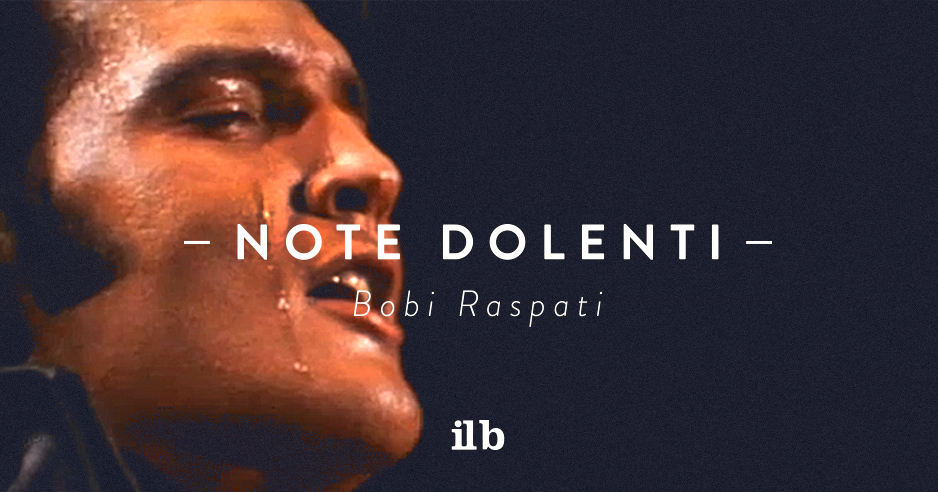di Bobi Raspati
In che modo Internet influenza la produzione musicale? In quale misura computer, social network e telefoni iperconnessi stanno determinando forma e sostanza delle musichine d’oggi? Abbiamo già parlato fino alle lacrime della nostalgia canaglia come chiave di lettura del nostro presente poetico, dalle malinconie balneari della chillwave ai rigurgiti indie (con il grande ritorno dalle zazzere alla Morrissey e dei chinos rossi, prossimamente sulle vostre zampette di hipster). Stavolta parliamo d’altro, e presentiamo un musicista eclettico che ben rappresenta vizi e virtù di questa buffa generazione di smidollati.
Kiran Leonard ha tanti brufoli quanti dischi all’attivo. Perché ha soli sedici anni, e questo è il suo tredicesimo album. Tocca dire che viene da Manchester, ma la sua provenienza è di scarsa rilevanza: Kiran viene dalla sua cameretta, dove scarica tonnellate di dischi, sfonda i vinili del babbo e si rovina con tastiere e chitarre. Invece che di playstation, di spinelli o calcetto, si bombarda di psichedelia e Pro Tools (per i meno avveduti, un programma per registrare e mixare, facilmente reperibile nel mondo dell’illegalità). Tutta la sua produzione sta su Bandcamp, la piattaforma digitale su cui i musicisti piazzano i propri dischi autoprodotti, in download per pochi dollari o più spesso aggratis. Come in questo caso: free download.
Ripercorrere la discografia di Kiran Leonard fa male alla capoccia. Nel 2008 il pischello aveva 12 anni e si prodigava in lunghissime suite di musica ambient (il disco untitled.ground e le due parti di Selected Passive Drones, sintetizzatori, organo e registrazioni ambientali). Un anno dopo già accresceva il proprio registro coi beat degli Autechre (l’EP Barbaraptuous) e brandellacci jazz-Nintendo alla Flying Lotus (the Maya Deren Broadcast Intrusion). Tipino eccentrico, nel 2009 si buttava sulla folktronica dei Books, con tanto di campionamenti televisivo-radiofonici, chitarra acustica e cantato sospiroso (The Sunshine Theory), mentre nel 2010 tentava l’IDM alla Four Tet (Moth Enters the Bright Lights). Nel luglio del 2011 si volta pagina: il jazz-rock barocco di The Big Fish segnala uno scatto coraggioso. Kiran adesso si diletta con batteria, basso elettrico e wurlitzer, mentre scaracchia interminabili assoli di chitarra elettrica, armonica a bocca e scolapasta. Parliamoci chiaro: tanta prolificità raramente s’accorda alla qualità e quasi tutti questi dischi sono raffazzonati e incompiuti. All’età in cui si formano i primi gruppi Kiran faceva (quasi) tutto da sè, ogni scoperta musicale accompagnata dal progetto di un album e da una registrazione. Prima che il pianeta fosse ricoperto di computer, un aspirante cantautore si portava dietro le proprie canzonette giovanili per anni, prima di poterle registrare. E se anche riusciva a registrarle era tutta roba impresentabile, che finiva a macerare assieme alle velleità adolescenziali in un cassetto. I cassetti di oggi sono le pagine di bandcamp e soundcloud, i canali di youtube, facebook e tumblr, e financo blog come questo.
Eppure va a finire che Bowler Hat Soup è una raccolta più che interessante. Composta nella sua interezza da canzoni piano-voce bizzarramente arrangiate, mostra qualità melodiche rarissime e un’interpretazione curiosamente solida. Non si tratta di essere benevoli («e pensa che ha solo sedici anni!!!», vi sento dire), questo è semplicemente un buon disco. L’iniziale Dear Lincoln è un numero frenetico alla Van Dyke Parks e Brunswick Street pare un Andrew Bird pastorale. Port-Ainé sfoggia la migliore armonia vocale del disco, sostenuta da un organo in surplasse e arpeggi di banjo. Il disco, incoerente come da programma, scorre tra vignette alla Daniel Johnston (‘Whysky Bath’), ballate in odore di Thom Yorke (‘Smilin’ Morn’) ed esplosioni chitarristiche (‘There’s No Future in Us’). La seconda parte, da ‘Oakland Highball’ a ‘Geraldo’s Farm’, evoca addirittura naso e baffi di Frank Zappa — tra reprise di pezzi già esplosi, frangenti noise e buffonate pianistiche. La chiusa è melodrammatica: ‘Hoopla Reprise’ (con la fantasmatica apparizione vocale di un’amichetta di Kiran) e l’accorata ‘A Purpose’ non sfigurerebbero troppo nelle opere di Sufjan Stevens o The Microphones.
Insomma, questo è un album sorprendente. Il ragazzo è giovane e non è affatto detto che si farà. Gran parte del fascino di questo disco sta proprio nelle imprecisioni e nella sfacciataggine del suo autore, ed è possibile che la mano ferma di un produttore non porterebbe grandi migliorie. Un album immaturo e pieno di ambizioni, quasi del tutto slegato da quel che si suona in giro e dunque fresco seppur fatto di ricicli assortiti. La cultura musicale eterogenea figlia del download selvaggio, software per registrare e mixare a portata di mano e hardware a basso costo, il coraggio di chi non ha un contratto da difendere e una piattaforma gratuita come Bandcamp: Internet è già nelle nostre teste, e talvolta porta idee meravigliose.