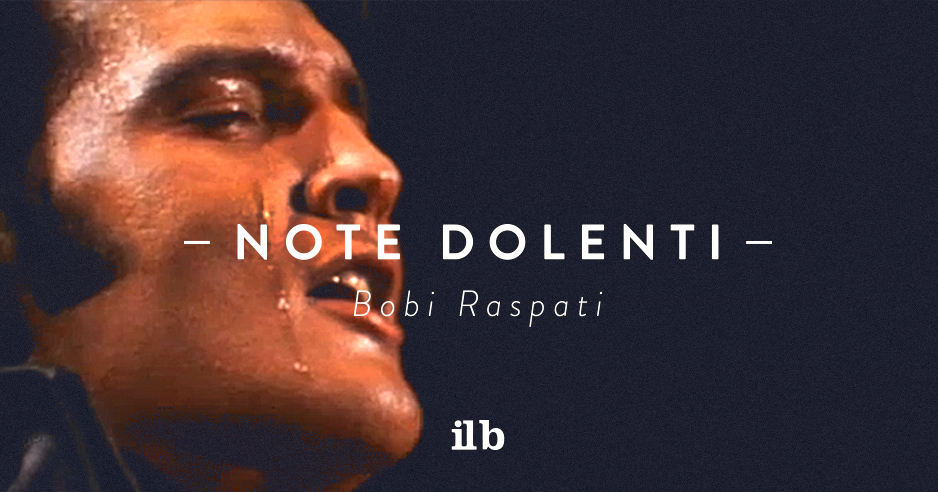di Bobi Raspati
Inutile farla lunga: il rock è maschilista. E le donne permalose, quindi dovrò andare coi piedi di piombo nel dire quel che voglio dire. E cioè che anche nel nostro mondo pentagrammico la creatività pare un vestito che gli uomini si sono tagliati addosso, lasciando alle donne la compostezza, il bel canto, e illusori spazi di emancipazione nell’ammiccamento scomposto (chi meglio incarna il punto di vista femminile tra Joni Mitchell e Madonna?). Certo è che proprio il rock rappresenta un campo di rinegoziazione dei canoni della femminilità (siccome sono pigro cito solo Runaways e riot grrls, L7 e Bikini Kills su tutte). Ma le cose non filano affatto bene. Care donne, vi confesso che ci resto molto male quando sento apprezzamenti scomposti sulla beltade (e pernacchie sulla voce imperfetta) di una come Joanna Newsom! Niente poi è più vischioso e biecamente discriminatorio che fare associazioni basate sul genere per tirare su un’inchiesta, un articolo, una quota rosa: e allora eccomi qui, dalla parte dei cattivi. Care donne, io di voi parlerei tutti i giorni! Il fatto è che questi sono dischi significativi ma insipidi, e quindi tanto vale metterli assieme. Chi vorrà criticare tale operazione faccia pure, o donne. Scrivetemi in privato, vi dedicherò le mie più servili attenzioni.
Grimes è lo pseudonimo col quale opera Claire Boucher, una sgallettata ventiquattrenne da Montreal. Due dischi indipendenti e assai chiaccherati, qualche mese fa l’esordio sulla prestigiosa etichetta 4AD con Visions. Ma soprattutto copertine e interviste nelle quali sbandierare il proprio orgoglio hipster, dal NME a Dazed & Confused, additata come nuova, ennesima icona femminile. Grimes posa per foto di moda, parla della propria sessualità e del proprio telefono, di fumetti e di cucito. Peccato però che questo album sia una rara porcata (con una bella copertina totalmente slegata dalla musica che dovrebbe rappresentare). Interamente composto col basilare programma GarageBand, trattasi di un synth-pop modesto e retrivo. Una mano di elettronica alla Kraftwerk su tiepidi beat UK garage, qualche melodia centrata e una voce languida e impalpabile. Ascolto dopo ascolto, qualche pezzo appare miracolosamente azzeccato (su tutte ‘Genesis’ e ‘Oblivion’) e troppe volte si sprofonda nella noia. Il succo pare essere proprio questo: quel che conta è il contorno, l’aura. Insomma, musica hipster, volatile come una twittata e ambigua come una camicia a scacchi. Basta? No, ma è talmente vacuo che può affascinare (5/6).
Julia Holter ha 27 anni e viene da Los Angeles, ha una formazione classica ma si dedica all’elettronica. Al contrario delle altre donzelle qui presentate non ha un’immagine accattivante e nemmeno carisma, ma una faccia anonima e un aspetto un poco sciatto (il che vi suggerisce che sia gran musicista e lavoratrice, ci scommetto…). Il suo esordio, Tragedy, era stato pubblicato manco un anno fa da una piccola etichetta indipendente, la microscopica Leaving. Ispirato da Euripide e Virginia Woolf, si trattava di un’ambient intellettualona e frigida, come una Laurie Anderson timidissima. L’album era stato scoperto dalla cricca di Wire, la controparte occhialuta del NME. Così la ragazza è stata tampinata a lungo, fino a che, qualche mese fa, non ha dato alle stampte Ekstasis (per la sempre piccina RVNG), etichettato come capolavoro prima ancora di aver fatto capolino nei consueti bazaar digitali. Ben più accessibile del suo predecessore, il disco ripropone ambient e bordoni, affettati battiti sintetici e loop vocali eterei, cristallini, liturgici e sepolcrali (gli aggettivi li prendo in prestito dai giornalisti bravi). Alla fine della fiera, il disco troverà tanti fan ma alle mie virili orecchie risulta stucchevole e un po’ povero (6).
Soap&Skin è il candido nomignolo della già pallida Anja Plaschg, un’austriaca di Graz che di anni ne ha appena 22. Anche se dalle nostre parti sembra un’assurdità, la ragazza ha già alle spalle un passato di tutto riguardo. Manco maggiorenne aveva esordito con un EP omonimo che mostrava tanta grazia compositiva e tanto carattere, nonché un’interpretazione niente male della strepitosa Janitor of Lunacy di Nico. Proprio l’algida crucca è il modello di riferimento per la musica di Anja: drammatiche ballate piano e voce, talvolta screziate da clangori elettronici alla Xiu Xiu, intonazione solenne e stolida, atmosfere cupissime. Il disco del 2009, Lovetune for Vacuum, era stato una splendida conferma (da sentire e risentire, tra le altre, ‘Cry Wolf’ e la struggente ‘Spiracle’), ed era stato promosso da gente (uomini) come Michael Gira e John Cale (il quale poi aveva messo addosso alla ragazzi i panni di Nico nel corso di un tour dedicato alla tetra musa). Il seguito è Narrow, ed è purtroppo una mezza delusione. Appena 28 minuti e appena otto pezzi, tra cui la ridondante cover di ‘Voyage Voyage’, due canzoni da ricordare (l’elegia funebre ‘Vater’, in tedesco, e la circolare ‘Wonder’) e quache giro a vuoto. La mia idea è che la ragazza abbia vestito i panni della maledetta troppo giovane e che si sia infine stufata, vivaddio. Tingersi i capelli di rosso non basta, a quanto pare, e la musica di Soap&Skin ripercorre il canovaccio dark senza troppa voglia. Cara Anja, sei giovane e nessuno ti corre dietro: la vita è bella, fatti ‘na risata e torna a trovarci quando ti pare (6).
Jennifer Herrema ha quarant’anni portati da cani, ma tra tutte queste rammollite fa un figurone. A fine anni ’80 era stata la Yoko Ono dei Pussy Galore (gloriosa band garage-punk capeggiata da Jon Spencer) e assieme al chitarrista Neil Michael Hagerty, in un tripudio di eroina e amore, aveva dato vita ai Royal Trux. Due album celeberrimi e famigerati (il beefheartiano esordio, omonimo, e il magmatico free-noise di Twin Infinitives), una tardiva disintossicazione e un pugno di ben più regolari album di blues elettrico e psichedelia (tra tutti, il mio preferito è l’acido Accelerator). Una voce spaventosamente roca, marcissima, una personalità fuori dal comune. Giovane e assai belloccia, aveva percorso le strade di Grimes due decenni fa, tra servizi fotografici e gallerie d’arte (icona drogatella, era persino finita nei manifesti di Calvin Klein e H&M). Mollato il suo sdentato sodale a una delirante carriera solista, la pulzella si era dedicata all’hard-rock chitarristico con i fallimentari RTX. In questi giorni torna sulla scena con un nuovo progetto, Black Bananas, e con un album eccessivo e spassoso, come sempre edito dalla gloriosa Drag City (il titolo è Rad Time Xpress IV). Ancora riff da far impallidire i Def Leppard, stavolta però impiastricciati nei synth e in dozzine di effetti elettronici (roba che i Justice recenti si sognano, per dire). Qualche beat hip hop (‘Hot Stupid’), qualche melodia intelliggibile (‘Killer Weed’). Pur nella povertà di canzoni riuscite, ascoltare questa roba con le cuffie rimane un’esperienza degna di essere vissuta. Tra le poche figure a saper stropicciare con coraggio stilemi ed estetica del rock classico, Jennifer Herrema continua a piacerci da matti, e siamo tutti felici del suo ritorno (6).